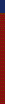Le rivoluzioni che all’inizio dell’anno hanno rovesciato i regimi autoritari in Tunisia e in Egitto e quelle che sono più o meno silenziosamente ancora in corso in altri paesi arabi hanno messo nuovo vento nelle vele di quelli che vedono in Internet uno strumento straordinario per l’avanzamento della democrazia. Il collegamento orizzontale fra coloro che possono accedere alle comunicazioni via telematica appare come la chiave di una nuova partecipazione alla vita pubblica. I cittadini si riapproprierebbero così della delega, vera o finta che sia, affidata ai politici di professione e definirebbero da sé, in prima persona, l’agenda delle decisioni. Le rivoluzioni, si afferma, avverranno d’ora in poi nel cosiddetto cyberspazio, lo spazio immateriale caratterizzato dall’uso dell’elettronica e dello spettro elettromagnetico per raccogliere, analizzare e scambiare informazioni mediante le reti informatiche e le relative infrastrutture. A volte il termine è anche usato per riferirsi a strutture che esistono ampiamente all'interno della stessa comunicazione dei network. Si potrebbe dire, per esempio, che un sito web esiste nel cyberspazio: e, analogamente, che quanto avviene su Internet non avviene dove si trovano fisicamente i partecipanti o i server, ma nel cyberspazio. Esso non dovrebbe però essere confuso con le reti Internet, che ne sono il supporto: si tratta di un luogo virtuale.
Il termine cyberspazio fu coniato dal romanziere canadese William Gibson negli anni Ottanta, in una prospettiva che vedeva il mondo dominato dallo strapotere delle grandi multinazionali entro una società dall'economia incerta, nella quale bande di disperati si combattevano nelle strade. L'unica speranza era di organizzare la rivolta attraverso il cyberspazio, la realtà virtuale di mondi digitali simulati. E tuttora a coloro che detestano il mondo attuale con le sue marcatissime differenze fra ricchi e non ricchi, fra forti e deboli, appare straordinariamente allettante l’idea che esso possa essere cambiato con una rivoluzione dal basso orchestrata via computer mediante Internet, Facebook e Twitter (un servizio gratuito di rete sociale che fornisce agli utenti una pagina personale aggiornabile tramite messaggi di 140 caratteri al massimo). E l’idea lo diviene ancora di più se si tiene conto del fatto che questa rivoluzione appare largamente non violenta. Si è così visto in questi ultimi anni e soprattutto in questi ultimi mesi ingrossarsi il fiume dei blog che parlano di questa potenzialità, definita invariabilmente “epocale”, accompagnato da un fiume quasi altrettanto imponente di articoli e servizi su quotidiani e periodici che ne descrivono le caratteristiche positive e i probabili sviluppi. Fenomeno ancora più significativo, anche molti uomini politici si sono lasciati attrarre dalla prospettiva e la guardano come molti capi di impresa guardavano a Internet negli anni Novanta: qualcosa che di per sé li avrebbe messi in condizioni di aumentare le vendite.
Tuttavia, se è fuori discussione che stia crescendo rapidissimamente il numero di coloro che possono accedere al cyberspazio, non tutti sono d’accordo sul fatto che si tratti necessariamente di una cosa positiva, soprattutto per quanto riguarda i suoi effetti politici. Secondo questi ultimi si dovrebbe invece riflettere di più sul fatto che ogni volta che è apparsa una nuova tecnologia di comunicazione si sono sprecate le anticipazioni sulla sua capacità di migliorare il livello del dibattito pubblico, di aumentare la trasparenza dell’attività politica, di ridurre il nazionalismo e di accelerare l’avvento del mitico villaggio globale, previsioni che poi sono state almeno in parte smentite. È stato così per le ferrovie, che secondo Karl Marx avrebbero abolito il sistema delle caste in India, e poi via via per il telegrafo, il telefono, la radio, gli aerei e la televisione. Miglioramenti ci sono stati, ovviamente, ma con un processo graduale e con frequenti salti all’indietro che hanno smentito l’ineluttabilità del progresso. Le speranze suscitate dai nuovi mezzi sono state inesorabilmente frustrate dalle dure forze della politica, della cultura e dell’economia. Infatti, generalmente parlando il potere è in grado di controllare gli eventi molto più di coloro che gli sono sottoposti. Tanto è vero questo che le rivoluzioni veramente riuscite, quelle cioè che hanno avuto effetti duraturi, sono state storicamente assai poche e hanno avuto successo soprattutto perché il potere si era indebolito o intorpidito, oppure aveva commesso errori clamorosi.
Un politologo bielorusso, Evgeny Morozov, che lavora attualmente negli Stati Uniti, si è fatto interprete, fra altri, di questi dubbi in un saggio apparso qualche mese fa su Public Affairs (The Net Delusion: The Dark Side of Internet, L’illusione della rete: il lato oscuro di Internet). Egli osserva che l’idea secondo cui Internet avvantaggi gli oppressi più degli oppressori è viziata da quella che egli chiama la cyber utopia, l’ingenua convinzione della capacità liberatrice della comunicazione online basata sul testardo rifiuto di vederne i possibili rischi. Neppure le rivoluzioni che hanno avuto inizio nel cyberspazio sono una promessa di avvento della democrazia. Vediamo del resto, si potrebbe aggiungere, che dopo gli entusiasmi iniziali, il processo di democratizzazione in Tunisia e in Egitto segna il passo: nel secondo di questi paesi sembra anzi profilarsi un regime basato sull’alleanza fra due forze, l’esercito e i Fratelli Musulmani, che in fatto di democrazia non offrono certo molte garanzie.
I cyber utopisti non vedono che i governi autoritari sono in grado di utilizzare Internet a proprio vantaggio a scopi di propaganda e che i modi per sottoporre le reti a censura possono essere molto raffinati e indiretti. Insomma, le rivoluzioni che hanno avuto inizio nel cyberspazio non sono di per sé una promessa di avvento della democrazia perché le stesse comunicazioni che vi avvengono possono non esserlo.
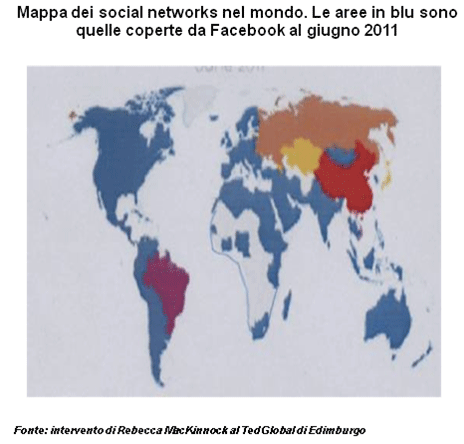
Nei paesi in cui possono avvenire i collegamenti via Facebook, che sono per lo più paesi a democrazia consolidata (vedi figura), i cosiddetti social networks riescono in genere ad assolvere alla funzione di aumentare la trasparenza nelle attività pubbliche. Fatta eccezione per il Giappone e il Brasile, che per ragioni culturali utilizzano sistemi propri diversi da Facebook, negli altri paesi le cose stanno alquanto diversamente. In Russia il governo appoggia, direttamente o indirettamente, un gran numero di siti che sono molto rapidi nel denunciare le responsabilità … dell’opposizione, approvano tutte le iniziative del governo e dedicano uno spazio crescente a programmi di intrattenimento. In altre parole, il governo adotta qui una strategia che punta a distrarre i cittadini, perfino anche offrendo loro programmi di buona qualità. Una strategia sottile e che sembra vincente: probabilmente il sistema migliore per controllare Internet non è quello che utilizza la censura più pervasiva e draconiana, bensì quello che elimina del tutto la necessità di una censura, perché il cyberspazio è in gran parte occupato. In Cina l’accesso dall’estero è bloccato dal cosiddetto “grande muro di fuoco”, mentre vengono istituiti premi per i siti che si autodisciplinano, cioè che si autocensurano. Stati come il Belarus e l’Iran pagano i bloggers per diffondere la propria propaganda e accedono alle reti private per monitorare i dissidenti, Inoltre, molto dipende da quanti computer ci sono in giro. A Cuba, per esempio, coloro che li possiedono sono pochi perché il governo ne ha ristretto la vendita alla popolazione, non ci sono Internet cafès mentre i blogger sono pochissimi e devono stare molto attenti a quello che scrivono. Le possibilità di interconnettersi ad altri utenti sono limitate e strettamente controllate. All’estremo vi sono poi paesi come la Corea del Nord, nei quali la popolazione è stata sottoposta a un lavaggio del cervello talmente intenso da creare enormi difficoltà psicologiche a chi volesse cominciare a cambiare la situazione utilizzando Facebook e Twitter.
Questo per quanto riguarda i paesi ancora soggetti a regimi più o meno autoritari (o che stanno cercando di liberarsene). Ma in realtà anche nei paesi a democrazia consolidata l’avvento dei social networks crea problemi politici tutt’altro che semplici. Essi sono stati messi in evidenza al convegno Ted Global, svoltosi a Edimburgo in luglio, soprattutto in un appassionato intervento di Rebecca MacKinnock, coordinatrice di GlobalVoices, una onlus che segue attentamente le vicende dei messaggi scritti dai blogger in tutto il mondo. Neanche in Occidente, ha osservato, sono mancati i tentativi da parte dei governi di intervenire sulle reti in chiave geopolitica. Un caso emblematico al riguardo è stato quello di Julian Assange e della sua WikiLeaks, che ha sconvolto le cancellerie di mezzo mondo (Roma inclusa) con la diffusione di informazioni ritenute molto sensibili. Il governo americano gli ha dato la caccia, eppure un reato specifico non gli era stato contestato (in Gran Bretagna era stato arrestato, e poi rilasciato, per un’accusa di abusi sessuali). Eppure, dall'insediamento di Obama l'amministrazione americana aveva più volte ribadito di ritenere Internet un grande strumento di democratizzazione, finanziando un programma da 30 milioni di dollari per realizzare strumenti anti-censura. In Francia vi sono stati tentativi di introdurre nella legislazione la dottrina cosiddetta dei Three Strikes, secondo la quale alla terza condanna per violazione dei diritti d’autore, con attenzione rivolta soprattutto alle trasmissioni televisive, scatta una punizione esemplare (una normativa molto rigida sul diritto d’autore minerebbe alla base la funzionalità di Internet). La Corte Costituzionale francese ha però poi bocciato il provvedimento: comunque, sull’onda di questa tendenza, l’italiana Mediaset ha chiesto a YouTube e Google 500 milioni di dollari di risarcimento «per illecita diffusione e sfruttamento commerciale di file audio-video di proprietà delle società del gruppo». In Gran Bretagna indignate proteste sono state levate contro il Digital Economy Act, una legge che sposta sui distributori privati l’onere di controllare i comportamenti degli utenti, con l’evidente scopo di intimidire i primi. Ma poi sono spesso le stesse aziende che producono software a esercitare una sorta di censura preventiva: la Apple ha escluso il settimanale tedesco Stern dall’impiego dei suoi prodotti ritenendo troppo audaci certe immagini da esso diffuse. E, in effetti, come garantire che il cyberspazio sia gestito nell’interesse pubblico quando la maggior parte dei capi delle imprese interessate si preoccupano esclusivamente di massimizzare i rendimenti degli azionisti?
La MacKinnon ha perorato la causa della massima libertà di comunicazione nell’uso del cyberspazio. Ma alla fine ha dovuto anche lei convenire sul fatto che, in un mondo in cui dominano le reti globali, perfino nelle società democratiche non ci sono risposte chiare all’interrogativo su come raggiungere un adeguato equilibrio fra le esigenze della sicurezza e dell’applicazione della legge, da una parte, e la protezione delle libertà civili e di parola, dall’altra. In sostanza, come è avvenuto per le precedenti grandi ondate di innovazione tecnologica, anche quanto agli effetti sulla politica e sulla democrazia della crescita esponenziale del cyberspazio le valutazioni sono ancora difficili e approssimative. Al minimo, nel formulare previsioni al riguardo la prudenza è d’obbligo.