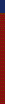A quasi due anni di distanza dall’ascesa al cancellierato di Angela Merkel è possibile e utile formulare una prima valutazione sui risultati ottenuti in Germania dalla Grosse Koalition bianco rosa fra cristiano democratici – cristiano sociali e socialdemocratici nonché sulle prospettive che si aprono all’economia tedesca. Questo tanto più in quanto gli andamenti economici dell’Europa sono molto connessi a quello che succede oltre Reno: se la ripresa in atto sarà duratura e soprattutto incisiva dipenderà molto da questo.
In Germania, in complesso, si respira un’aria ottimista. Nonostante alcune incertezze sulle scelte operative, il governo ha saputo dare un’idea di quel che si propone abbastanza coerente da rassicurare gli ambienti tanto imprenditoriali quanto sindacali sul fatto che il paese è in grado di riprendere il suo ruolo tradizionale di locomotiva dell’economia europea. Anche gli organismi internazionali guardano con fiducia al nuovo corso tedesco, a cominciare da quando, circa un anno fa, l’OCSE ha espresso un giudizio molto positivo sui primi passi del nuovo governo. Gi indicatori economici sono al rialzo (vedi grafico): risalta in particolare il fatto che la risalita del prodotto lordo e della produzione industriale venga ottenuta in un contesto di prezzi stabili.
I primi anni del secolo sono stati anni di ristagno economico per la Germania, tanto che non pochi osservatori hanno parlato di crisi strutturale del modello economico tedesco. In realtà, sotto la superficie era in corso un ampio processo di ristrutturazione dell’economia, soprattutto di quella industriale, con l’obiettivo di ottenere al più presto consistenti e duraturi guadagni di produttività, quale premessa indispensabile per mantenere e migliorare la competitività internazionale. I risultati parlano da soli: la Germania ha non solo mantenuto, ma addirittura migliorato, le sue posizioni sui mercati mondiali, nonostante l’emergere della Cina, dell’India, eccetera. Già nel 2005 il paese aveva realizzato una bilancia commerciale record, con un surplus nell’ordine di 160 miliardi di euro: tutto lascia supporre che la Germania continuerà a consolidare la sua posizione di primo esportatore mondiale di manufatti, davanti agli Stati Uniti e alla Cina. Non c’è dubbio che questo risultato sia dipeso soprattutto dall’immagine consolidata da quasi 60 anni del “made in Germany” come sinonimo di qualità e affidabilità dei prodotti: ma è anche vero che l’avere riguadagnato posizioni sul fronte della competitività di prezzo ha fatto la differenza che ha consentito l’impennata dei risultati.
Nel medio – lungo periodo la politica economica del governo di coalizione si pone cinque priorità. La prima è il rilancio della ricerca e sviluppo: nel quadro della Agenda di Lisbona l’obiettivo fissato è di pervenire entro il 2010 a dedicarvi almeno il 3% del prodotto interno lordo, il che significherebbe un investimento nell’ordine di 75 miliardi di euro, una cifra impressionante, che metterà la Germania in grado di vedersela su questo piano con il Giappone e forse perfino con gli Stati Uniti. La seconda è lo stimolo all’economia mediante incentivi fiscali soprattutto alle imprese. La terza è lo sviluppo dei trasporti pubblici, nei quali saranno investiti 4,5 miliardi di euro. La quarta è l’aiuto alle famiglia, per ragioni tanto di equità sociale quanto di stimolo ai consumi. L’ultima priorità, infine, è l’incentivazione del lavoro a domicilio, sotto forma di telelavoro e simili.
Molto importante è anche il nuovo corso impresso alla politica energetica. Le tensioni sui mercati mondiali dell’energia e delle materie prime sono motivo di gravi preoccupazioni anche per una economia forte come quella tedesca che, come del resto le altre econome europee, dipende dall’estero per i suoi approvvigionamenti: per il 97% quanto al petrolio, per l’82% quanto al gas e per il 59% quanto al carbone. L’elettricità consumata proviene per i due terzi da oltre confine, dalla Russia in primo luogo, e con questo paese i rapporti sono molto meno idilliaci di una volta. La politica energetica si sta quindi orientando verso la diversificazione degli approvvigionamenti e contestualmente verso lo sviluppo di fonti rinnovabili, soprattutto quella eolica, mentre viene perseguita la decisione di rinunciare all’energia nucleare entro il 2021, nonostante il 30% dell’elettricità consumata provenga attualmente dalle 17 centrali di questo tipo in funzione (ma su quest’ultimo punto forse l’ultima parola non è ancora stata detta).
Più controversi gli aspetti riguardanti la politica di bilancio e quella strettamente connessa della previdenza sociale. Il governo vuole rientrare nel parametro di Maastricht riportando il debito pubblico dal 3,3% del 2006 al 2,5% nel 2007. a questo scopo ha programmato una riduzione della spesa pubblica nell’ordine di 35 miliardi di euro e contestualmente un aumento dell’IVA dal 16 al 19% a partire dall’inizio di quest’anno. Il provvedimento ha, com’è ovvio, suscitato un mare di proteste, soprattutto per il timore di un’ulteriore contrazione dei consumi privati, già stagnanti fin dall’adozione dell’euro e ulteriormente penalizzati dai diffusi timori di disoccupazione, che fanno loro anteporre il risparmio. D’altra parte, le misure in via di attuazione da parte del governo comprendono anche una riduzione degli oneri sociali per aumentare la competitività delle esportazioni (secondo alcuni commentatori si tratta di una “disinflazione competitiva”), nonché un aumento dal 42 al 45% dell’imposizione fiscale sui redditi più alti. Infine, per fronteggiare l’aumento della durata media della vita si punta a un aumento dell’età pensionabile da 65 a 67 anni entro il 2012, mentre alle imprese si richiede di assumere più anziani: infatti, solo il 42% degli uomini con oltre 55 anni ha ancora un impiego. Allo scopo di favorire la natalità, bassissima quasi quanto in Italia, alle donne si prospetta la possibilità di consentire alle donne di prendere congedi di maternità di 12 mesi.
La Merkel, comunque, si è rivelata capace anche di avanzare proposte audaci. Appena dopo aver preso il potere ha sostenuto, forse riferendosi al suo predecessore Gerhard Schroeder, che dopo aver superato il nazionalismo politico in Europa occorre superare anche quello economico. “Sono convinta che potremo godere di tutte le opportunità offerte dal mercato unico solo se decidiamo di sviluppare campioni europei in settori quali l’elettricità e i servizi postali”, ha affermato. E all’inizio di quest’anno ha proposto di creare un mercato unico fra Europa e Stati Uniti. Con qualche venatura pedagogica verso gli americani, ha ricordato che l’esperienza in materia degli europei potrebbe essere messa a frutto nella creazione di questa nuova gigantesca area di libero scambio. Proposte che restano per ora al livello di intenzioni, ma che dimostrano una notevole apertura mentale rispetto ai problemi posti dalla globalizzazione incalzante (anche se poi in sede europea i tedeschi non sempre si comportano in maniera coerente a queste intenzioni: per esempio, insieme ai francesi essi continuano a opporsi alla liberalizzazione della distribuzione di elettricità).
La Germania sta effettivamente tornando a essere la locomotiva d’Europa e uno dei motori dell’economia mondiale. Risultati – e programmi – che fanno quindi venire l’acquolina in bocca a chiunque in Italia si interessi alle sorti economiche del paese. Eppure, un problema importante irrisolto c’è e se la sua non soluzione perdurasse, esso potrebbe mettere a repentaglio i brillanti risultati ottenuti altrove: si tratta della disoccupazione, su livelli molto elevati fin dagli anni Novanta e che era ancora poco sotto il 10% all’inizio di quest’anno (contro il 6,8% in Italia). Le maggiori imprese industriali traboccano di utili ma questo non si traduce in un aumento dell’occupazione, anzi: negli ultimi cinque anni l’industria ha perduto quasi 800 mila occupati e l’edilizia oltre 600 mila. Per migliorare la loro competitività, i settori industriali investono in impianti e attrezzature e riducono l’occupazione a decine di migliaia di persone alla volta. È vero che l’occupazione aumenta nei servizi, ma non in misura sufficiente ad assorbire questa massa di espulsioni.
Per tutto il periodo postbellico fin quasi alla fine del secolo la Germania ha saputo coniugare brillantemente l’efficienza economica con l’edificazione del migliore Welfare State che sia mai apparso sul pianeta. Gli aumenti di produttività e quindi di reddito andavano di pari passo con quelli della protezione sociale estesa al maggior numero possibile di persone. Era questo il senso della Soziale Marktwirschaft, l’economia sociale di mercato teorizzata negli anni Cinquanta da Ludwig Erhardt, il leggendario ministro dell’economia (e poi cancellerie) della ripresa e del miracolo tedesco. Ma più o meno nel corso degli anni Novanta questa capacità di coniugare gli opposti è venuta in buona parte meno. Il lungo governo socialdemocratico è sembrato privilegiare la protezione sociale sulla crescita economica e la competitività: ora forse sta accadendo il contrario. In un commento apparso su Die Welt Thomas Straubhaar, direttore dell’Istituto di Economia Mondiale di Amburgo, ha teorizzato quasi brutalmente questo rovesciamento di posizioni. Prendendo a prestito una frase di Edmund Phelps, l’ultimo premio Nobel per l’economia, “Ci sono state due pessime idee economiche nel ventesimo secolo, il comunismo e il corporativismo (ovviamente, intendeva tutt’altro di quel che questo termine significa in italiano), noto anche come economia sociale di mercato”. Quest’ultima, ha aggiunto Straubhaar, in realtà non è di mercato e forse non è neppure sociale. L’economia di mercato non ha bisogno di aggettivi: quanto meglio questa funziona, tanto più facile è aiutare i deboli. Ergo, per favore, lasciate fare al mercato e il resto si risolverà da sé.
Già, ma la disoccupazione non scende, almeno per ora. Ed è possibile che ci troviamo di fronte a un fenomeno nuovo: come negli anni Settanta contrariamente alla teoria economica ortodossa l’inflazione avvenne in situazione di crescita nulla o negativa (“stagflazione”), così adesso, sempre contro la teoria, una buona crescita si salda a persistente disoccupazione (manca il termine corrispondente). Il confronto con gli Stati Uniti, dove la crescita avviene contestualmente a una bassa disoccupazione, porta inevitabilmente a porsi la domanda se i vincoli posti dallo Stato sociale, proprio perché in Germania più efficiente che altrove, non siano ancora troppo elevati per consentire il riassorbimento della disoccupazione. Dalla risposta che il governo tedesco saprà dare a questo intricato viluppo di questioni, dipenderà in definitiva la continuazione e l’irrobustimento della ripresa economica in Germania e quindi anche in Europa e in Italia.