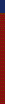|
Le imprese e la crisi internazionale: la tentazione del breve termine
Esistono sistemi, modelli o modalità di comportamento collaudati ai quali le imprese possono fare ricorso quando esplode una gravissima crisi internazionale? Per rispondere a questa domanda occorre inquadrarla in uno schema di ragionamento più ampio. La letteratura di orientamento sia manageriale, sia politico – economico ha affrontato in modo abbastanza ampio e sistematico due problemi per così dire contigui a questo, vale a dire la valutazione dei rischi a cui una azienda può esporsi col fatto stesso di svolgere una data attività e la natura delle crisi che possono investirla. Per esempio, vi è una sostanziale differenza fra le crisi che sorgono all’interno di una impresa da quelle che sorgono invece al suo esterno. Tra le prime vi sono quelle che derivano dalla denuncia pubblica di un grave difetto di un prodotto: un noto caso recente ha riguardato nel 2000 i pneumatici Bridgestone montati sulle vetture della Ford. Tra le seconde, vi sono gravi eventi internazionali, come le guerre del Golfo e del Kossovo, azioni criminose contro una data azienda o le sue installazioni, provvedimenti di governi ostili (confische, tassazioni inique, divieto di vendere dati prodotti), catastrofi naturali e simili.
Tuttavia, questa stessa letteratura si è occupata soprattutto di come valutare il rischio di insorgenza di una crisi – e cioè di cosa fare prima che essa insorga – e, fra le crisi, prevalentemente di quelle che hanno origine interna. Però dopo i tragici avvenimenti a New York e a Washington dell’11 settembre scorso le aziende praticamente di tutto il mondo si trovano di fronte non più a un problema di prevenzione, ma a quello di come fronteggiare le conseguenze di una gravissima crisi internazionale esplosa improvvisamente. In altre parole, si tratta sempre di fronteggiare una crisi, cioè di crisis management, ma una già in atto e di cui si cominciano già a valutare le enormi conseguenze.
In linea di principio, la possibilità di superare una crisi senza troppi danni dipende essenzialmente da due fattori: il tempo necessaria a identificarla, o a identificarne le conseguenze, e la velocità di reazione. Quanto al primo fattore, la faccenda è complicata in questo caso dal fatto che le conseguenze economiche possibili della crisi – quelle che ovviamente alle imprese interessano di più – si innestano su una congiuntura già cedente, tanto da aver già fatto evocare lo spettro della recessione. I due spaventosi attentati peggioreranno ulteriormente la situazione? Nell’immediato, certamente: vi sono già settori direttamente e durissimamente colpiti, come il trasporto aereo, il turismo, i consumi finali in genere, che infatti chiedono a gran voce aiuti e sostegni. Ma a termine più lungo? Secondo alcuni, la domanda globale potrebbe addirittura essere stimolata dagli investimenti per la ricostruzione nelle due città colpite e da quelli in nuovi apparati di monitoraggio e di difesa, per i quali la spesa si annuncia massiccia in tutto il mondo. Tuttavia è evidente che a questo riguardo ogni azienda fa storia a sé.
La lettura della nuova situazione non è certo facile. Eppure è necessario compierla e compierla rapidamente, altrimenti si compromette la possibilità di mettere in gioco il secondo fattore, la velocità di reazione alle manifestazioni della crisi. Si tratta di decidere al più presto se occorre cambiare una o più configurazioni prodotti – mercati, se tagliare dei costi e quali, se introdurre modifiche organizzative, se orientarsi in nuove direzioni. Qui le aziende medie o minori possono, almeno in teoria, avere un vantaggio rispetto a quelle più grandi, che sono rallentate nei processi decisionali dalla loro stessa complessità. Lo sforzo è certo notevole ma sarebbero penalizzate le imprese che non lo compissero.
Ad ogni modo, una crisi, e specialmente una grave crisi esterna, aumenta il coefficiente di incertezza di cui le aziende devono tenere conto quanto prendono delle decisioni. Lo si è visto tante volte, in occasioni di tensioni e conflitti, ma anche di violente fluttuazioni sui mercati dei cambi, di improvvise insolvenze di paesi fortemente debitori, di brusche impennate dell’inflazione. In questi casi vi sono due tentazioni tipiche che lusingano le direzioni aziendali: ridurre l’orizzonte temporale di riferimento, cioè pensare solo a breve termine, e tagliare o rinviare gli investimenti. Sono tentazioni comprensibili, ma alle quali si deve cedere solo se questo appare inevitabile dopo avere molto riflettuto, perché cedervi implica un rischio elevato, quello di compromettere le prospettive stesse dell’impresa. Una strategia complessiva è valida solo se riesce a coniugare l’esigenza di gestire il presente con quella di preparare il futuro.
Infine, anche se è vero che nelle forme da essa assunte questa tragedia era imprevedibile, si conferma ancora una volta che la identificazione preventiva delle crisi potenziali e delle possibili risposte ad esse è sempre più un compito fondamentale del management. Essere comunque preparati ad affrontare delle crisi mette molto meglio in grado di gestire quelle che poi si presentano realmente, anche se hanno carattere e forma diversa da quelle che si erano ipotizzate.
Antonio Martelli
|