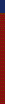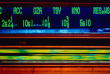
|
|
Investitori istituzionali e manager: rischio finanziario e rischio... d'impiego
di Antonio Martelli
|
Nel corso degli anni Novanta i mercati finanziari hanno attraversato più trasformazioni strutturali che in tutto il secolo precedente. Una delle più significative fra queste, in effetti cominciata anche prima, è la crescente sostituzione come investitori di altri soggetti alle singole persone.
Più precisamente, mentre prima queste ultime investivano direttamente in Borsa, oggigiorno tendono sempre più a farlo attraverso degli intermediari, quali i fondi comuni di investimento, i fondi pensione, le banche d'affari, eccetera, in una parola i cosiddetti investitori istituzionali. Inoltre, il risparmio incanalato per questa via tende sempre più a assumere una dimensione internazionale: una quota crescente di esso, infatti, varca i confini dei singoli paesi per collocarsi là dove sembrano presentarsi le migliori opportunità.
I fattori che hanno dato impulso a questo fenomeno sono diversi e per lo più abbastanza conosciuti: anzitutto, l'integrazione dell'economia mondiale, quindi la deregolazione dei mercati finanziari e ancora le privatizzazioni, che hanno buttato sul mercato molti milioni di nuove azioni (non sempre queste potevano essere assorbite all'interno dei singoli paesi). Del resto, gli investitori istituzionali si sono rivelati molto efficienti nella raccolta del risparmio: infatti i risparmiatori vengono sollevati dai rischi e dagli oneri connessi a operare in Borsa e per di più hanno l'impressione che, combinando le loro risorse, avranno più voce in capitolo nella gestione delle aziende in cui si è investito.
Forse meno noto, quanto meno al grosso pubblico, è invece che lo stesso fenomeno pone su basi abbastanza nuove il problema dei rapporti fra detentori del capitale e management di queste imprese. Nuove non tanto in termini qualitativi, perché problemi del genere si ponevano anche prima, ma quantitativi, perché è di gran lunga cresciuto il numero di imprese in cui il capitale degli investitori istituzionali - per lo più di molti investitori istituzionali contemporaneamente - è presente in misura significativa e spesso è addirittura maggioritario.
Fra investitori istituzionali e dirigenti d'azienda i motivi di contrasto, per non dire conflitto, prevalgono nettamente su quelli di armonia. Con l'avvento dei primi, infatti, i mercati finanziari sono diventati molto più fluidi, in quanto le risorse che essi mettono a disposizione si muovono rapidamente dalle azioni di un'azienda a quelle di un'altra, in genere in base alla valutazione delle migliori opportunità che si offrono e usualmente a breve termine. Inoltre, questi investitori detengono portafogli di azioni molto diversificati, costituiti da centinaia o anche migliaia di piccole quote in altrettante aziende. In parte questa frammentazione è indotta, in particolare negli Stati Uniti, dalla legislazione antimonopolistica e dintorni; in parte invece è legata a politiche di diversificazione del rischio, vale a dire alla ricerca del giusto rapporto fra rischio e redditività, nonché alla forte propensione alla liquidità tipica dei "nuovi" investitori.
Le differenze che esistono da questo punto di vista fra i vari mercati finanziari non devono trarre in inganno. E' naturalmente vero che gli investitori istituzionali americani hanno obiettivi quasi esclusivamente finanziari, misurati mediante il confronto trimestrale dei rendimenti dei loro portafogli con quelli complessivi del mercato azionario. Invece in Europa, soprattutto nella variante tedesca, e in Giappone, gli investitori istituzionali, ivi inclusi in questo caso le banche, sono più coinvolti nella gestione permanente delle aziende, fino a far parte in molti casi dei loro consigli di amministrazione. In generale, tuttavia, si può dire che gli interessi delle due controparti divergono in ambedue i casi, anche se con intensità differenti. Infatti, gli investitori istituzionali puntano fondamentalmente a massimizzare i rendimenti dei loro capitali. Invece i dirigenti puntano in primis alla stabilità e poi all'espansione dell'azienda, per vari motivi di cui comunque il più importante è che, per dirla in parole semplici, in questo modo si massimizzano le occasioni di avanzamento e di carriera, sia dentro sia fuori l'azienda (il termine "dirigenti" va qui inteso in senso lato, comprendendovi non solo i manager esecutivi, ma anche quanto meno i consiglieri di amministrazione). A un rischio di portata in genere modesta o minima, quello dell'investitore istituzionale che ha messo i suoi soldi in una data azienda, se ne contrappone uno molto grave o totale, quello che corrono i dirigenti se la loro azienda va male. Alcuni osservatori giungono addirittura a vedere il il "rischio di impiego" come un contraltare strutturale del "rischio finanziario"…
In molti casi, la divergenza in questi due tipi di interessi viene superata di fatto: ciò avviene soprattutto quando e finché i risultati ottenuti dall'azienda interessata sono positivi. In altri, e forse sono la maggioranza, ciò non avviene e ne possono derivare, anzi spesso ne derivano, tensioni dannose o perfino esiziali. Questo si verifica quando al più o meno latente conflitto di interessi si somma anche un conflitto di ruoli, che per un motivo o per l'altro non si riesce a comporre. Fondamentalmente, i dirigenti sono meglio informati sull'impresa e sul settore o segmento di settore in cui essa opera, per cui tendono a valutare in quest'ottica le sue prospettive di sviluppo. Invece gli investitori istituzionali dispongono di una visione più ampia delle sue concrete possibilità finanziarie: inoltre, dispongono di molti più segnali sugli andamenti dei mercati e sono anche in grado di interpretarli meglio. Per di più, devono a loro volta fare i conti con le aspettative dei "creditori di ultima istanza", vale a dire i singoli individui che hanno affidato loro i loro risparmi e vogliono vederli fruttare senza troppe ambasce.
Il risultato netto di queste differenze è che si sta manifestando una discrasia piuttosto pericolosa. Gli investitori istituzionali lamentano di non essere in grado di esercitare pienamente i loro diritti di proprietà, anzitutto per la resistenza, più o meno mascherata, dei management aziendali. D'altra parte un conflitto scoperto, se troppo prolungato, finirebbe col compromettere proprio l'investimento azionario che essi vorrebbero preservare, il che fornisce ai dirigenti una comoda copertura nei confronti degli errori che possono aver commesso. Dal canto loro, però, i manager protestano per quella che labellano come crescente inframmettenza degli investitori nella gestione anche spicciola delle aziende e citano i casi abbastanza frequenti in cui al primo stormir di foglie i fondi investiti in azioni vengono liquidati, danneggiando così l'azienda, se non addirittura facendola precipitare in vite. Per non parlare poi del contributo che in questo modo viene dato alla instabilità dei mercati finanziari e al rischio che, a furia di punture di spillo, la bolla speculativa finisca con lo scoppiare.
Inoltre, agli investitori istituzionali si imputa di essere i principali responsabili delle scalate, ostili o no, al controllo delle imprese: indubbiamente, nei mercati finanziati evoluti le scalate sono inevitabili e ineliminabili, ma è anche vero che spesso esse rispondono a finalità più speculative che strategiche, con danni per le aziende che ne sono oggetto. Più ancora, attraverso gli investitori istituzionali è più facile esercitare indirettamente pressioni sui dirigenti per indurli ad adottare strategie diverse da quelle che avevano in mente: la caduta del titolo Olivetti fra la primavera e l'autunno del 1999 per indurre Roberto Colaninno a rivedere radicalmente il piano di riassetto societario di Telecom è un esempio recente di pressioni di questo tipo adottate con successo.
E' l'inframmettenza, se così si può chiamare, degli investitori istituzionali nella gestione delle imprese un fenomeno destinato a una crescita inarrestabile? Una risposta affermativa a questo interrogativo poteva sembrare scontata fino a poco tempo fa: adesso, con la diffusione pandemica di Internet e la possibilità offerta ai singoli di operare direttamente in Borsa con un semplice modem le prospettive non sono più tanto chiare. Lo scenario più probabile, comunque, è quello che nel futuro a medio - lungo termine vede ancora questi investitori come protagonisti importantissimi dei mercati finanziari, anche se forse non con un ruolo schiacciante rispetto ai soggetti privati. E' certo quindi che essi continueranno a essere una sfida primaria per le direzioni aziendali: di qui la necessità che i dirigenti di dedichino con crescente impegno ad apprendere la difficile arte di governo di questi processi innovativi.
|