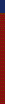La strategia è indubbiamente il filone più
rigoglioso nello sviluppo recente della teoria e pratica della gestione d’impresa. Divenuta ormai
una disciplina accademica a pieno titolo, nonché la competenza più apprezzata e ambita della
professione consulenziale, essa presenta una amplissima varietà di contenuti e di approcci, che
per di più sono solo in parte aziendalistici o anche più ampiamente economici. Il nuovo libro di
Antonio Martelli intende andare alla radice del problema strategico, ricercando soprattutto nel
rapporto fra incertezza, complessità e strategia le chiavi per spiegare come sopravvivere e
svilupparsi in un contesto dinamico come quello attuale.
A questo scopo viene presentata una mappa dei
contributi che sono stati elaborati negli ultimi decenni proprio per affrontare l’incertezza e la
complessità: le teorie dei segnali, dei giochi, del negoziato e del caos. La strategia è, in
ultima analisi, un tema interdisciplinare, qualunque sia il contesto in cui si vuole pensarla e
applicarla. Nell’analizzare il processo di formazione e di attuazione della strategia occorre
quindi tenere conto di una molteplicità di fattori disomogenei: anche per questo molti degli
esempi che appaiono nel libro sono tratti da contesti diversi da quello economico, per ricercare
nella biologia, nella genetica e nell’antropologia le analogie con i sistemi adattivi, non
meccanicistici, che sono i più idonei a spiegare come sopravvivere e svilupparsi in un contesto
dinamico come quello attuale. Un aspetto specifico del libro è che i contributi dei vari autori
sono presentati inquadrandoli storicamente, cioè anche come risultato di un certo percorso
evolutivo.
Antonio Martelli, Alle radici della strategia,
Le Monnier,
Firenze, 2005, pag. 285. € 20,40.
Per l'impresa
distrettuale è il momento di scelte difficili
Appare sempre più evidente, dalle difficoltà che
sta attraversando, che l’industria italiana non è stata allenata da regole severe a muoversi in un
ambiente competitivo, perché quelle che c’erano sono state rimosse o allentate nella fase
involutiva degli anni Settanta e Ottanta. Per cui, da quando negli anni precedenti alla crisi
valutaria del 1992 e poi a partire dal 1995 sino a oggi è stata esposta da un lato a un cambio
meno favorevole e dall’altro ai rigori della concorrenza esterna, essa ha fatto e fa sempre più
fatica a tenere il passo con i cambiamenti in atto nel sistema economico mondiale.
L’industria italiana è anche affetta da nanismo:
anzi, forse questa è la causa più immediata della sua perdita di slancio. A questa realtà non
sfuggono i distretti industriali, che pure sono stati lo sviluppo più interessante realizzato
dall’industria italiana negli ultimi decenni e che inoltre sarebbero da un certo punto di vista
comparabili ad aziende medio- grandi. Il loro modo tradizionale di operare – una competizione –
cooperazione spontanea - non funziona troppo bene quando si passa dalla mera
internazionalizzazione mercantile, vale a dire delle esportazioni e poco più, alla necessità di
insediarsi nei mercati esteri con reti distributive stabili, con insediamenti produttivi autonomi
o in joint - venture e, al livello più avanzato, con attività di ricerca e sviluppo.
Secondo un principio elaborato dall’eminente
economista inglese Alfred Marshall fin dai primi del Novecento, la concentrazione spaziale della
produzione – cioè il fenomeno per cui molte aziende piccole e medie che producono le stese cose si
concentrano in un’area geografica relativamente ristretta - si verifica e dà luogo ad economie di
agglomerazione quando un bene viene prodotto in presenza di significativi rendimenti crescenti di
scala. Tutto lascia supporre che da questo punto di vista i distretti industriali italiani abbiano
progressivamente perduto posizioni nei confronti delle produzioni concorrenti localizzate
soprattutto nell’Oriente asiatico (ma anche altrove).
Oltre alle dinamiche del mercato mondiale
globalizzato, altre pressioni per il cambiamento derivano poi dalla evoluzione delle tecnologie:
costante riorganizzazione e ridistribuzione delle fasi di lavorazione, necessità di operare in una
molteplicità di reti, informatizzazione delle funzioni aziendali, eccetera. Il dover operare in
contesti competitivi più ardui che in passato nonché di confrontarsi con concorrenti che
beneficiano di vantaggi incolmabili sul costo del lavoro e di vantaggi crescenti anche su altri
fattori, obbliga a sviluppare costantemente specifiche competenze nella innovazione di prodotto e
della distribuzione. Queste ultime in particolare appaiono alquanto ardue da ottenere nei nostri
distretti industriali, che sono nati e si sono sviluppati in base a una vocazione molto più
produttiva che commerciale. A ogni modo, l’esigenza di affrontare cambiamenti complessi tanto
nell’area della produzione quanto in quella commerciale rendono ancora più stringenti i limiti
causati dal già citato nanismo delle nostre strutture industriali. Si tratta di dimensioni troppo
contenute per compiere investimenti rilevanti, di sottocapitalizzazione, della resistenza ad
aprire il capitale a finanziatori esterni, di competenze imprenditoriali e manageriali troppo
circoscritte e troppo poco disponibili al cambiamento.
Le difficoltà dei distretti sono in realtà le
difficoltà dell’impresa distrettuale, che in quanto tale è stata oggetto di un’attenzione
relativamente minore. Eppure si tratta dell’elemento essenziale, senza il quale il distretto non
potrebbe neppure esistere e che quindi dovrebbe costituire l’elemento centrale di ogni analisi su
di essi.
Tanto il distretto, quanto l’impresa distrettuale
italiani sono sottoposti in questo periodo a un impetuoso vento di cambiamento. E’ ben vero che,
nonostante negli ultimi lustri la grande impresa abbia in larga parte rioccupato la posizione
centrale come spiegazione dello sviluppo, i sistemi di produzione locali si sono rivelati capaci,
in una certa misura e per un certo tempo, di resistere all’urto della globalizzazione. Ma
proprio per questo la complessità dei problemi che le imprese distrettuali devono affrontare è
oggi molto maggiore che venti o anche solo dieci anni fa: e le articolate e variegate
classificazioni proposte per interpretarlo riescono solo in parte a cogliere un processo di
trasformazione tanto vasto e profondo. A maggior ragione, l’impresa distrettuale, che di quelle
trasformazioni è l’agente principale, presenta notevolissime difficoltà gia a essere individuata
come tale e poi a essere analizzata e spiegata nelle sue origini, nei suoi comportamenti e nel suo
sviluppo.
Che cosa è, in definitiva, un’impresa
distrettuale? Al di là della sua localizzazione e delle sue caratteristiche, un’impresa
distrettuale è tale perché la sua appartenenza a un distretto è una scelta strategica: e quindi
essa rimane tale finché quella scelta non cambia. Naturalmente, appartenere a un distretto
industriale non significa escludere appartenenze ad altri livelli, per cominciare a un ambiente
più ampio e articolato del distretto stesso. Ma il distretto come scelta di strategia, destinata a
durare nel tempo, ne condiziona l’attività, le relazioni, gli scambi, la conoscenza e anche le
informazioni in base alla quali essa agisce.
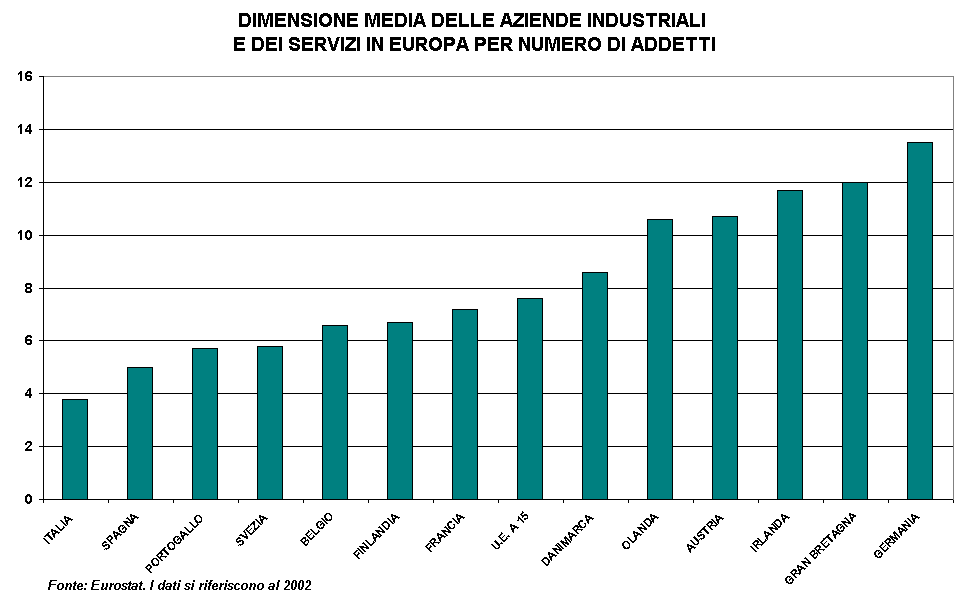
La sfida derivante dalle pressioni concorrenziali
soprattutto da parte dei paesi emergenti – che operano negli stessi settori in cui l’Italia è
leader e dai quali dipende in ultima analisi la sua posizione nell’arena competitiva
internazionale – obbliga però tanto i distretti quanto le aziende distrettuali italiani a
ripensare a fondo la loro stessa ragion d’essere. Sia pure con lentezza, anche il sistema
istituzionale comincia a rendersi conto di questa realtà, come mostra per esempio il fatto che
qualche anni fa la Regione Lombardia ha riconosciuto l’esistenza del metadistretto – una
evoluzione del distretto tradizionale caratterizzata dalla concentrazione nella stessa area di più
settori produttivi (la cosiddetta multisettorialità) e dalla grandissima rilevanza che in essi
assumono la ricerca, la tecnologia e la produzione di conoscenza.
Alle imprese distrettuali spetta però il compito
più arduo: arricchire in misura decisiva le loro capacità competitive adottando strategie e
politiche di innovazione ad ampio raggio. Nonostante la grande varietà nelle tipologie e nelle
caratteristiche di questi tipi di imprese, il restringersi dei cicli di vita dei prodotti e dei
servizi le obbliga ad accelerare i loro processi innovativi. Questo significa sviluppare
largamente la loro base di conoscenze, affinare la loro capacità di gestione strategica,
mettersi al passo con le dinamiche ambientali, settoriali e della competizione internazionale. E
forse proprio su questo punto possiamo individuare la differenza nelle condizioni in cui devono e
dovranno operare le imprese distrettuali rispetto al passato. Una volta far parte di un distretto
era una condizione necessaria e molto spesso sufficiente per assicurare a certi tipi di imprese
una decorosa sopravvivenza, se non proprio la crescita. Oggi per gli stessi tipi di imprese farne
parte è una condizione ancora necessaria, ma solo di rado sufficiente, in modo particolare per chi
punta a un vero sviluppo. All’impresa distrettuale e al suo imprenditore si pongono quindi scelte
e traguardi molto più difficili che in passato: ma anche molto più ricchi di possibilità. In più,
oltre ai problemi che le investono in quanto appartenenti ai distretti industriali, le imprese
distrettuali devono affrontare anche complessi problemi di transizione generazionale e, in misura
crescente, anche di assetto societario.
Il problema più difficile da risolvere è che la
necessità di lavorare in modo differenziato rispetto alle situazioni dei singoli distretti deve
trovare il suo baricentro a livello di sistema (bisogna “fare sistema” si sollecita da tante
parti), il che presuppone una forte capacità di coordinamento a livello centrale, tale da
valorizzare senza frustrarle le potenzialità locali. Finora, l’integrazione in Europa, che è stata
essenziale e decisiva per il raggiungimento praticamente in tutto il paese di elevati livelli di
benessere, non è lo è stata altrettanto per la ricomposizione, anche solo tendenziale, delle
divergenze fra aree diverse. Anzi, in diversi casi la assenza o carenza di strategie specifiche a
livello nazionale, lo scarso raccordo fra analisi e politiche adottate di conseguenza e quello
ancora più insufficiente fra anticipazione e governance ne hanno addirittura accentuato la
portata.
La difficoltà di fare sistema si traduce allora
nell’impoverimento delle filiere e nell’indebolimento del vantaggio competitivo: il che a sua
volta determina la riduzione della capacità di attrazione delle aree in cui i distretti sono
collocati. Non è quindi sorprendente che, nel contesto europeo, l’attrattività dell’Italia e delle
sue aree locali per gli investimenti provenienti dall’esterno rimanga a un livello inferiore alla
media europea, come i dati sugli investimenti esteri in Italia dimostrano abbondantemente. In
queste condizioni, e in assenza di attenzione e di adeguati interventi a livello dei policy
makers nazionali e locali, anche il tradizionale punto di forza italiano rappresentato dai
distretti industriali potrebbe quindi trasformarsi – se questo non sta già avvenendo – in un punto
di debolezza.
(pubblicato sul numero di ottobre 2005 di
Uomini & Business)