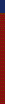Le sorprese che ci riservano le nuove tecnologie informatiche e soprattutto Internet sono davvero senza fine (e senza limiti). Dopo avere invaso e rivoluzionato le comunicazioni, gli uffici, le fabbriche, le case di abitazione, gli ospedali, i sistemi di difesa e molti altri campi ancora, ora ci lasciano intravedere per un domani abbastanza prossimo – e forse perfino già per oggi – una delle più straordinarie evoluzioni sociali e politiche che sia dato di immaginare: la nascita delle nazioni virtuali.
Nazioni virtuali? Ma come può una nazione essere virtuale? Ernest Renan, il grande pensatore francese del tardo Ottocento, non aveva forse spiegato con cartesiana lucidità che una nazione è un’anima, un principio spirituale, il punto di arrivo di un lungo passato di sforzi, di sacrifici e di dedizione, il tutto incarnato in una popolazione? Suvvia, una nazione deve pur essere incardinata in qualcosa per essere vitale, delle persone, una cultura, un territorio, tutte cose che di virtuale non hanno proprio nulla. Ci deve essere un abbaglio.
E invece no. Due consulenti americani, Mike Dillard e Janet Hennard, con una lunga esperienza rispettivamente nella gestione della tecnologia e nel management strategico a lungo termine, sostengono che le nazioni virtuali stanno proprio per nascere, anzi che qualcuna è già nata e attiva. Ciò che le rende possibile è proprio la pandemia di Internet: la rete mette a disposizione un terreno fertile sul quale persone animate da una causa o un credo comune possono formarle. E creare in questo modo uno straordinario potenziale per migliorare lo stato del mondo mediante un sapiente impiego della cooperazione, della sicurezza comune, delle risorse. Oppure per peggiorarlo, impiegando le stesse cose per fini perversi.
Bisogna dire che il termine “nazione” si presta a equivoci. Quando Renan rifletteva sul concetto di nazione, dopo l’umiliazione inflitta alla Francia dalla Prussia nel 1870 e in un’epoca di esasperati nazionalismi, aveva in mente quelli che oggi si chiamerebbero la cultura e i valori comuni. In questo senso la nazione è diversa dallo stato: l’Austria, cioè l’impero absburgico multinazionale dei suoi tempi, egli osservava, era uno stato, ma non una nazione. In inglese il termine “nazione” è più generico: Adam Smith chiamò la sua opera La ricchezza delle nazioni e in tempi recentissimi Michael E. Porter ha intitolato la sua Il vantaggio competitivo delle nazioni, laddove un autore continentale europeo avrebbe forse usato il termine “paesi”. La questione non è certo di lana caprina: a distanza di quasi 150 anni dall’unità, noi italiani non abbiamo ancora capito bene se siamo una nazione oppure no, ma è difficile negare che l’Italia sia un paese.
Comunque, i due americani il termine lo usano tanto nel senso di Renan – di cui probabilmente ignorano il nome – quanto nel senso di Smith e Porter. Per loro, una nazione virtuale nasce dalla possibilità offerta a persone di tutto il mondo di riconoscersi come una comunità a parte e di elaborare piani per il proprio futuro. Una nazione del genere è qualcosa di più e di diverso dai gruppi, ormai innumerevoli, che riuniscono attraverso Internet persone con interessi, culturali, materiali o di altra natura, comuni (alcuni dei quali, tra l’altro, si definiscono “nazioni virtuali” senza avere affatto le caratteristiche di quelle studiate e ipotizzate dai due analisti). Una vera nazione virtuale si costituisce quando uno di questi gruppi, o anche un gruppo nuovo, si da scopi collettivi sostanzialmente identici a quelli di una nazione – o paese o stato – tradizionale: la protezione dei suoi membri, il loro benessere fisico e spirituale, i loro interessi economici e , soprattutto, il potere. Le condizioni di base perché una nazione virtuale passi da potenziale a effettiva sono due: un accesso affidabile a comunicazioni dirette fra i suoi membri e una causa significativa per la quale i suoi membri siano disposti a impegnarsi.
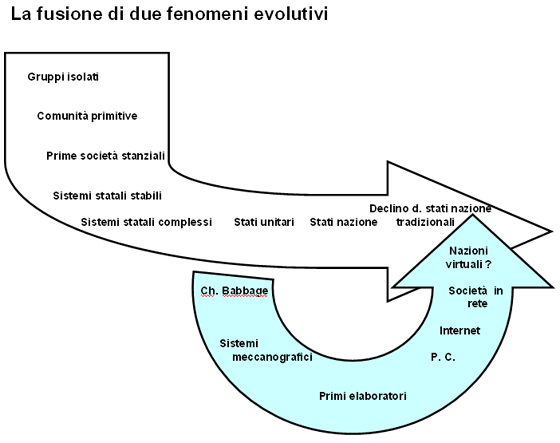
(adattato da Dillard e Hennard)
Per venire al concreto, essi forniscono due esempi di nazioni virtuali. Uno, una società di Dallas, la Lifecast, che si era specializzata nelle comunicazioni on – line fra persone molto ricche e influenti, può essere trascurata, in quanto non opera già più. Ma l’altro è molto più inquietante: si tratta infatti di Al Quaeda.
Nella scelta c’entrerà magari l’ossessione americana per il terrorismo dopo l’11 settembre dell’anno scorso, ma questa organizzazione le caratteristiche di una nazione virtuale nel senso di Dillard e della Hennard le possiede entrambe. Essa è stata formata nel 1988 da un gruppo di fondamentalisti islamici che non disponevano, in quel momento, letteralmente di nulla. Ma la sua data di nascita coincide più o meno con l’avvio di Internet come fenomeno globale. Da allora, essa non ha fatto che rafforzarsi, cementandosi intorno a una causa sentita dai suoi membri come immanente, vale a dire il riscatto dell’islamismo dalle umiliazioni inflittegli dal mondo occidentale, nonché intorno alla fedeltà incondizionata al suo capo, Osama Bin Laden. Essa è organizzata in cellule, è attiva in oltre 40 paesi, dispone di risorse finanziarie enormi derivanti da imprese industriali e commerciali, manipolazioni finanziarie, enti benefici e via dicendo. Ha dimostrato in Afghanistan di essere in grado di prendere in ostaggio, per persona neanche tanto interposta, un intero paese (il che tra l’altro le ha consentito, fino alla cacciata dei Talebani, di trarre profitto dalla produzione del 70% dell’eroina grezza prodotta nel mondo). E internet resta di gran lunga il suo principale strumento di comunicazione interna.
Del resto, la nascita delle nazioni virtuali potrebbe essere vista anche come un fenomeno evolutivo. Che Internet e le comunicazioni on – line siano destinati a modificare profondamente le strutture e regole del gioco dell’economia, della tecnologia, della società e della politica non lo nega ormai più nessuno. Che una delle molte evoluzioni possibili sia la nascita di comunità fondate da interessi, valori e ideologie condivisi e con legami fra i membri più stretti e forti di quelli fra i membri di comunità di altro tipo, politiche, religiose o anche statali, è una eventualità che appare possibile, per non dire probabile. E poi c’è un precedente molto chiaro. La storia del comunismo internazionale, dal 1917 al 1989, è anche la storia di un insieme di persone di tutto il mondo la cui lealtà primaria andava all’ideologia comunista e alla sua struttura portante, il partito, non certo al paese di cui avevano il passaporto. Per quel legame ognuna di quelle persone si sentiva affratellata a decine di milioni di altre che non conosceva in tutti il mondo: e per quella vera e propria nazione virtuale era disposta almeno in teoria (ma in molti casi anche in pratica) a morire, uccidere e fare molte altre cose, buone e cattive. E’ vero che i comunisti potevano contare su una base reale delle dimensioni dell’Unione Sovietica e dei suoi alleati: ma è anche vero che non avevano Internet…
Il dibattito seguito alla provocazione insita nel concetto stesso di nazione virtuale ha registrato, come spesso accade, alcuni favorevoli e parecchi contrari. Naturalmente le prove dell’esistenza di nazioni virtuali, pur essendoci, sono ancora insufficienti a elaborare una analisi teorica adeguatamente approfondita e convincente. E magari, lo si è già detto, il termine “nazione” non contribuisce molto a chiarire il fenomeno, anche se poi la proposta alternativa, quella di “comunità virtuale” crea più difficoltà di quante ne risolve. In più, la virtualità stessa del fenomeno è premessa della sua volatilità: le nazioni virtuali, o comunque si voglia chiamarle, potrebbero formarsi, trasformarsi e disfarsi con tale rapidità da non consentire di capire che cosa davvero stia loro succedendo. Ma dopotutto proprio Renan aveva suggellato la sua analisi affermando che una nazione è un plebiscito di tutti i giorni: e se c’è qualcosa che consente plebisciti quotidiani questa è proprio Internet.
Un commentatore serio e acuto come Harlan Cleveland, già ambasciatore degli Stati Uniti e ora presidente dell’Accademia Mondiale delle Arti e delle Scienze, ha osservato che il concetto di nazione virtuale si basa su una contrapposizione esasperata fra “virtuale” e “reale”, mentre nella realtà la distinzione è molto più sfumata. Vero. Ma ragionando così si apre la strada a ritenere possibile proprio uno degli scenari ipotizzati da Dillard e Hennard, vale a dire la trasformazione delle nazioni virtuali in nazioni reali. Una nazione virtuale cioè potrebbe, nel tempo, diventare tanto potente da pretendere per sé un territorio su cui installarsi e dal quale esercitare un potere sovrano. Forse dovremo abituarci a cambiamenti tanto continui della carta geografica mondiale da far apparire come uno scherzo quel che è accaduto nei Balcani durante gli anni Novanta dello scorso secolo. Un’ipotesi da incubo, per tutti i pericoli di destabilizzazione che porta con sé: non sorprende che di fronte a eventualità di questo tipo molti preferiscano ritenere che le nazioni virtuali non ci saranno mai.