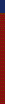Per parecchi secoli l’amministrazione delle imprese è vissuta sulla scia di quanto un brillante matematico (e frate francescano) di Borgo San Sepolcro, Luca Pacioli, aveva statuito nella sua Summa de aritmetica, geometria, proportioni e proporzionalità, pubblicata nel 1494. Essa contiene, oltre gli ordinari calcoli commerciali dell’interesse, delle cambiali, dei cambi e di quant’altro, anche la prima esposizione della contabilità a partita doppia. Con gli opportuni aggiornamenti e ampliamenti, questa impostazione è pervenuta fino al giorno d’oggi, contribuendo in misura decisiva a fare della gestione razionale delle attività economiche il bastione fondamentale dello sviluppo di marca occidentale.
In un sistema economico costituito essenzialmente intorno a transazioni commerciali tra aziende, nonché tra aziende e clienti finali, questa impostazione ha svolto la sua funzione in modo praticamente perfetto. Misurando e riportando nei bilanci gli effetti di tali transazioni si può ottenere un quadro completo ed esauriente del valore di qualsiasi impresa (se i dati e i conteggi sono veritieri, ovviamente). Ma al giorno d’oggi, sostiene fra molti altri Baruch Lev, professore di contabilità e finanza all’Università di New York e considerato uno dei massimi esperti mondiali della misurazione dei beni intangibili, l’impostazione mostra tutti i suoi anni: e questo perché sta divenendo sempre più riduttivo ricondurre le attività di impresa alle sole transazioni commerciali.
Infatti, il modello tradizionale di contabilità misura l’accumulazione e la concentrazione del capitale di un’azienda mediante il calcolo dei costi: esso dà cioè per scontato che il costo sostenuto per acquisire un bene capitale rende conto con sufficiente esattezza, tenuto conto del tempo, di quanto essa valga. Ma questo modello non funziona più molto quando i beni che rappresentano quel capitale non sono tangibili. Per esempio, i costi sostenuti per acquisire conoscenza hanno un rapporto molto meno certo con il relativo valore o prezzo di quanto ne abbiano i costi sostenuti per produrre, poniamo, un’automobile o una tonnellata di polistirolo o una pezza di tessuto. Quando l’economia era dominata dalla produzione industriale, un’idea non poteva acquistare valore se non le si riuniva intorno un sistema misurabile di beni tangibili, che servivano a realizzarla e sfruttarla. Oggigiorno non è più così, le idee hanno valore di per sé.
Già negli anni Ottanta si era cominciato ad avvertire il peso crescente delle risorse invisibili o intangibili fra gli asset aziendali. Ricerche come quelle di Charles Goldfinger negli Stati Uniti e di Hiroyuki Itami in Giappone avevano sottolineato che tutte le decisioni strategiche avevano qualche impatto sulle risorse invisibili, ma che a loro volta il tipo e la quantità di queste risorse condizionava sempre di più le decisioni strategiche. Una delle ragioni fondamentali di ciò è che queste risorse costituiscono, tra le altre cose, dei segnali molto tempestivi dell’andamento economico e finanziario di un’impresa, per cui un loro monitoraggio attento consente sia di migliorarne il processo decisionale strategico sia di preservarne nel tempo la capacità competitiva.
Le risorse intangibili sono di vario tipo: il know-how e le competenze aziendali, l’immagine e il posizionamento di mercato, la capacità di soddisfare le attese dei clienti, eccetera. Ma all’interno stesso di quella che potremmo definire la silenziosa rivoluzione degli intangibili stanno aumentando rapidamente il ruolo e l’importanza del cosiddetto capitale intellettuale.
Cosa è il capitale intellettuale? Una definizione accettabile, quanto meno come ipotesi di lavoro, può essere la seguente: capitale intellettuale è l’insieme di tutte le conoscenze che le persone di una organizzazione possiedono e che la mettono in grado di aumentare costantemente il valore che produce. E proprio nel concepirlo così emergono molte delle ragioni per cui la grande maggioranza delle imprese di tutti i paesi – con poche ma significative eccezioni – non riesce ancora a scorgerne il potenziale di crescita e di profitto, il ROI potenziale. Da gran parte delle imprese gli investimenti in impianti e attrezzature con flussi di cassa facili da misurare vengono valutati e giustificati con maggiore fiducia degli investimenti in quelle attività, formazione, addestramento, ricerca e sviluppo, che contribuiscono alla crescita del capitale intellettuale ma il cui potenziale è più arduo da quantificare.
In realtà, il capitale intellettuale consiste tanto nell’insieme delle conoscenze incardinate nelle persone quanto negli strumenti capaci di accrescerne le prestazioni e le potenzialità. In definitiva esso è costituita da tre grandi aree generatrici di valore: le persone, l’organizzazione e l’ambiente esterno. Le persone rappresentano il capitale umano, cioè l’insieme delle conoscenze, competenze e capacità delle persone che lavorano entro l’organizzazione. L’organizzazione o capitale strutturale, è l’insieme dei know-how codificati all’interno della struttura, della capacità di innovazione, dell’efficienza dei processi operativi, della coesione del management, della coerenza della cultura aziendale con la strategia. L’ambiente esterno, o capitale relazionale, è il patrimonio delle relazioni instaurate con gli interlocutori esterni dell’organizzazione.
Oggigiorno nessuna impresa dovrebbe permettersi di impiegare il proprio capitale intellettuale in modo inefficiente. Il primo compito per farvi leva sopra dovrebbe perciò consistere nel collocare le relative risorse nel contesto appropriato: in altre parole, nel mettere nella giusta relazione il capitale umano con il capitale strutturale e con il capitale relazionale. Le due dimensioni fondamentali al riguardo sono certamente il valore aggiunto prodotto dalle singole persone e la loro sostituibilità (vedi grafico).
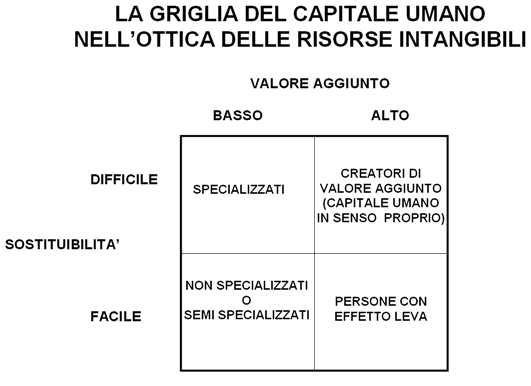
Nel quadrante in basso a sinistra trova posto la mano d’opera non specializzata o semi specializzata: l’organizzazione può averne bisogno, anche in quantità rilevanti, ma il suo successo non dipende da loro in quanto individui. Non vi sono difficili problemi di sostituzione e il tempo di formazione è breve. Ciò non toglie che adeguati sistemi di monitoraggio dovrebbero essere posti in atto anche per quanto riguarda questo tipo di persone: le buone idee possono venire da qualsiasi parte. Ma non ci si aspetta che esse vengano prodotte qui in modo sistematico.
Nel quadrante in alto a sinistra vanno inseriti coloro che svolgono mansioni complesse, cioè gli specializzati. In genere essi non sono creatori di elevato valore aggiunto, ma sono difficili da sostituire. Anche qui occorrono un buon monitoraggio nonché adeguati sistemi di reclutamento e formazione, per prevenire possibili crisi.
Nel quadrante in basso a destra trovano posto coloro che svolgono mansioni rilevanti per i clienti, ma che sono fungibili in quanto individui. Molti di coloro che operano qui possiedono un rilevante effetto leva, in quanto possiedono competenze che, pur non essendo specifiche di una data organizzazione, sono più preziose per un’azienda che per un’altra.
Infine, nel quadrante in alto a destra vanno inseriti coloro che creano un elevato valore aggiunto e sono difficilmente sostituibili come persone in quanto svolgono ruoli difficilmente sostituibili. Il vero e proprio capitale umano di un’organizzazione, di un’impresa, si trova qui. Forzando un tantino l’immagine, si potrebbe dire che qui si trova la parte del patrimonio aziendale costituita dal capitale umano, mentre gli altri tre quadranti rappresentano quasi esclusivamente il costo del lavoro. Quanto maggiore è per una impresa l’intensità del capitale umano, quanto maggiore è cioè la percentuale di lavoro ad alto maggiore aggiunto svolta da persone difficilmente sostituibili, tanto più essa può far pagare per i propri beni e servizi e tanto meno vulnerabile sarà perciò rispetto all’ambiente esterno. Quindi le organizzazioni più consapevoli e preveggenti investono quanto più possono nelle persone che si trovano in questo quadrante. Riguardo alle persone che si trovano negli altri, esse si comportano in modo articolato. Nei non – specializzati cercano di spendere il meno possibile. Quanto agli specializzati cercano di informatizzare al massimo il loro lavoro, in modo da aumentare il contenuto di informazione a scapito del contenuto puramente materiale di quanto esse producono.
Quanto infine alle persone con effetto leva, queste organizzazioni scelgono volta per volta fra esternalizzarne le relative attività, liberandosi dal dover investire in competenze non esclusive, oppure differenziare, cercare cioè di trasformare la conoscenza generica in qualcosa che possano sfruttare, oppure sfruttare in modi esclusivi, esse sole
Le tecniche contabili per attribuire alle risorse intangibili e al capitale intellettuale in particolare dei valori affidabili sono ancora ai primi passi e ci vorrà tempo perché siano perfezionate e si diffondano fra le aziende. La gestione del capitale intellettuale è quindi come un oceano scoperto di recente, di cui non esiste ancora una mappa e di cui pochi dirigenti d’azienda conoscono le dimensioni. E’ chiaro che navigarlo è un’arte difficile: ma chi la apprende per tempo riuscirà di certo a superare le tempeste che l’ancora più vasto oceano del cambiamento economico e tecnologico prospetta davanti a noi.