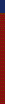Quella che stiamo attraversando non è la prima rivoluzione informativa, bensì la quarta. La prima è stata l’invenzione della scrittura in Mesopotamia cinque o seimila
anni fa, la seconda quella del libro, avvenuta in Cina verso il 1300 a.C..
La terza è stata l’invenzione della stampa da parte di Herr Gutenberg verso il 1450 della nostra era: e le conseguenze di questa invenzione sono un grande insegnamento su quello che potrà accadere in seguito a quella attualmente in corso.
Prima dell’avvento della macchina stampatrice esisteva in Europa una fiorente industria dell’informazione. Essa era basata sui monaci che, nei loro conventi e lavorando dall’alba al tramonto, trascrivevano libri con una produttività media di quattro pagine ciascuno al giorno. Con una media di 300 giorni lavorativi per forse 10.000 monaci si ottenevano 12 milioni di pagine all’anno, che divise per una media di 300 pagine per volume davano circa 40.000 volumi all’anno. In Europa si producevano quindi queste poche decine di migliaia di volumi, che costavano anche un sacco di soldi. Del resto, quelli che erano in grado di leggere erano pochissimi.
L’avvento della stampa cambiò radicalmente la situazione. All’inizio del Cinquecento i monaci erano out of business: ognuna delle ormai innumerevoli stamperie era in grado di produrre almeno 25.000 libri all’anno e la produttività continuava ad aumentare. Le conseguenze di questo cambiamento strutturale furono enormi, a cominciare dalla caduta del prezzo dei libri. Ormai anche famiglie di contadini relativamente poveri potevano comprarsi una copia della nuova Bibbia tradotta da Martin Lutero in tedesco: di qui la Riforma protestante e tutto quel che ne è seguito, come per esempio la diffusione della conoscenza e l’inizio di quella “liberazione dalla magia” che è stata in definitiva il programma della modernità.
Ma chi furono i protagonisti della rivoluzione della carta stampata? gli stampatori? Solo per un breve periodo. Già alla fine del Cinquecento erano stati sostituiti dagli editori, perché se loro padroneggiavano la tecnologia, questi controllavano i contenuti, cioè le informazioni. E la stessa cosa avverrà con la rivoluzione informativa centrata sui computer e sulle telecomunicazioni, afferma il formidabile guru del management Peter Drucker. Quelli che trarranno il massimo vantaggio dalle nuove, pervasive tecnologie non saranno i relativi tecnici, ma i manager (e tra questi, un po’ sorprendentemente, soprattutto i numbers crunchers, quelli che gestiscono le operazioni, in senso molto lato i managers del controllo dei costi e dei prezzi). Si, perché anche stavolta le informazioni sono molto, molto più importanti delle tecniche per elaborarle.
Questo tuttavia a patto che i manager accettino la sfida del cambiamento e si preparino a gestire le nuove tecnologie a proprio vantaggio. A questo scopo devono anzitutto liberarsi dei vecchi paradigmi del management, ormai desueti. In loro luogo occorre partire dalla constatazione che la tecnologia e gli utilizzatori finali, lungi dall’essere i fondamenti della strategia e politica delle organizzazioni, ne sono invece i limiti, mentre i fondamenti sono i valori percepiti dai clienti e le decisioni che questi ultimi prendono sulla allocazione del loro reddito disponibile. Dal punto di vista economico il grande problema del secolo appena iniziato è di ottenere dal segmento a più rapida crescita della popolazione lavorativa, i knowledge workers, quelli che applicano alle attività conoscenze sempre più specializzate, la stessa produttività che nel secolo appena conclusa è stata ottenuta dai lavoratori manuali.
Da diversi decenni Drucker non cessa di stupirci con le sue anticipazioni, anche perché per lo più esse sono state poi confermate dai fatti. In passato, i suoi giudizi un po’ taglienti e la sua evidente smania di liquidare perentoriamente tutto quello che non gli piace possono essere dispiaciuti a molti. Questo libro, tuttavia, rispetto ai precedenti, ha un tono insolitamente calmo. E’ come se, verso la conclusione di una lunghissima e fortunatissima carriera, quest’uomo, tra gli ultimi ad avere conosciuto la grande Vienna intellettuale degli anni Venti e Trenta, abbia voluto rassicurare sul fatto che il futuro ha in serbo più promesse che minacce: e che per avvantaggiarcene il nostro compito, come avverte nell’ultimo capitolo, è soprattutto quello di imparare a gestire noi stessi.
Antonio Martelli