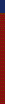Vi è un largo consenso sull’idea che il capitalismo sia senza paragone il sistema più efficiente nella produzione e distribuzione della ricchezza, ma che per organizzare alle sue spalle il consenso ha bisogno di intermediari – e di regolatori - efficaci, di cui il più importante è di gran lunga la democrazia: il capitalismo funziona bene se la democrazia funziona molto bene.
A questo scopo, è necessario che i cittadini sentano di partecipare e in una misura consistente ai vantaggi che il capitalismo può offrire. L’esperienza del governo della signora Thatcher in Gran Bretagna può essere variamente giudicata, ma non c’è dubbio che, facendo di milioni di lavoratori anche milioni di azionisti, ha notevolmente irrobustito la democrazia sostanziale del suo paese. Che poi a trarne vantaggio siano stati anche i suoi avversari laburisti è una ulteriore conferma che la democrazia britannica è in ottima salute.
Anche questa, un definitiva, è stata un’esperienza di partecipazione, tutta giocata però entro uno schema di capitalismo diffuso, certo, ma anche abbastanza tradizionale. Altre esperienze, più avanzate, di partecipazione hanno avuto finora minore – ma non secondaria – diffusione. In particolare, la partecipazione finanziaria, che significa la partecipazione dei dipendenti al capitale azionario dell’impresa in cui lavorano, emerge (o meglio riemerge) ora come un tema molto attuale nel dibattito politico ed economico in corso, in Europa come in Italia.
La partecipazione finanziaria è appunto il tema dell’ultima raccolta antologica de L’impresa al plurale. Quaderni della partecipazione, la rivista diretta da Guido Baglioni e che si è già guadagnata molta attenzione da parte di coloro che si occupano dei temi attinenti ai rapporti fra proprietà e lavoratori nelle imprese e alla valorizzazione delle risorse umane. Il numero raccoglie una quarantina di saggi e contributi di molti fra i più attivi e informati esperti della materia e costituisce nel suo insieme una panoramica di grande interesse sullo stato dell’arte della partecipazione finanziaria in Italia in questa fase della sua evoluzione economica e sociale.
Che cosa è, più precisamente, la partecipazione finanziaria? E’ una delle dimensioni della partecipazione attiva dei lavoratori alla vita e allo sviluppo delle aziende in cui lavorano. In alcuni paesi essa è diffusa da tempo: fra gli altri proprio negli Stati Uniti, ritenuti non sempre a ragione il bastione del capitalismo più chiuso all’innovazione nelle relazioni fra capitale e lavoro. I piani ESOP (Employee Stock Ownership Plans) lanciati venti anni fa coinvolgono migliaia di imprese con oltre 8 milioni di dipendenti. Ma sviluppi importanti sono avvenuti e sono in corso anche in Francia, nella stessa Gran Bretagna e in Svezia (piano Meidner), oltre che in altri paesi europei. E’ da notare che le tradizioni manageriali e sindacali di questi paesi sono profondamente diverse fra loro.
La partecipazione finanziaria si manifesta con molteplici modalità e non sempre con i medesimi obiettivi. Essa riguarda sì i dipendenti di una data impresa, ma è tale solo se avviene in modo collettivo, se cioè i dipendenti stessi si associano in modo da rappresentare un soggetto unico che difende interessi collettivi. E’ quindi opportuno distinguerla da altre forme di partecipazione: la public company, che può estendersi ai non dipendenti dell’impresa, i fondi pensione, che di solito hanno un ambito esterno all’impresa, p.e. la categoria, le stock options, che sono individuali. L’associazione può avvenire nelle forme più varie: fondi chiusi, cooperative, associazioni di fatto, mentre i diritti possono essere esercitati anche attraverso società fiduciarie. Le finalità possono essere di due tipi, che non si escludono necessariamente a vicenda, ma sono certamente distinti. La prima è distributiva, come negli ESOP: il risparmio dei dipendenti viene investito in azioni delle loro imprese. La seconda è strategica, in quanto si pone l’obiettivo di avere “voce in capitolo” nelle decisioni strategiche, cioè quelle veramente importanti, mentre dovrebbero essere escluse le decisioni operative (anche se la distinzione non è sempre facile). E’ più incerto e oggetto ancora di dibattito se la crescita di una associazione dei dipendenti debba portare necessariamente alla rivendicazione di una rappresentanza nel consiglio di amministrazione dell’impresa interessata: la soluzione più accettata è quella secondo cui la questione va affrontata e risolta caso per caso, azienda per azienda.
In Italia la partecipazione finanziaria è ancora in der Kinderschuhen, direbbero i tedeschi, sta muovendo i primi passi (ma i tedeschi stessi si sono prevalentemente orientati verso una strada diversa, quella della cogestione). In realtà vi è da noi una ricca tradizione di pensiero favorevole a questa strada per tagliare alla radice la separazione fra capitale e lavoro: basti pensare alla scuola cattolica e a quella mazziniana (“capitale e lavoro nelle stesse mani”, un’intuizione feconda, ma troppo in anticipo sui tempi). Tuttavia, le realizzazioni concrete sono state per lungo tempo assai scarse. Un notevole impulso è però venuto verso la fine degli anni Novanta dal massiccio programma di privatizzazioni, nonché da alcune disposizioni della cosiddetta Legge Draghi del 1998, che agevola la destinazione di quote non trascurabili di azioni ai dipendenti nel quadro degli aumenti di capitale e regola l’esercizio dei relativi diritti sociali. Il fronte ha così cominciato a muoversi: sono nate parecchie associazioni, poi raggruppatesi nella FIADA, Federazione Italiana Azionisti Dipendenti Aziende, con obiettivi di coordinamento, di studio e di proposta. Inoltre in materia erano state presentate ben cinque diverse proposte di legge (Alemanno, Pizzinato, Mulas, Vegas e Montagnino), poi decadute per la fine della legislatura. Però il quadro legislativo resta ancora poco orientato a favorire la partecipazione finanziaria, mentre sussistono diffidenze tanto sindacali quanto da parte del mondo imprenditoriale. Manca ancora, in definitiva, una consapevolezza diffusa circa il valore di questo tipo di partecipazione come strumento – assieme a molti altri, ovviamente – per rafforzare la tenuta del sistema economico, sociale e in definitiva anche politico.
Il compito che si assume chi si impegna a favorire la partecipazione finanziaria dei dipendenti delle imprese è quindi un compito difficile. Esso potrà essere agevolato se il legislatore sarà disposto a prenderlo in esame in uno spirito nuovo, di apertura a una visione diversa da quella del passato dei rapporti fra imprese e lavoratori. In questo senso, L’impresa al plurale ha tracciato con il suo contributo una mappa completa e articolata delle cose da fare e degli ostacoli da superare.
Antonio Martelli