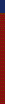Nell’immaginario collettivo occidentale un mito occupa praticamente da sempre un posto d’onore: l’attesa di Armageddon, del Doomsday, del giorno del giudizio finale. Negli anni Ottanta, due economisti americani, Charles Maurice e Charles Smithson, si fecero un certo nome analizzando e smontando questo mito fin dalle sue origini ai tempi della Grecia classica, se non prima. I suoi adepti non se ne sono dati per inteso, anzi sono diventati se possibile più numerosi e più accesi. Ma poiché le varie profezie di sventura vengono regolarmente smentite dai fatti, il mito dell’inevitabile tramonto della nostra civiltà, anzi di qualsiasi civiltà, deve trovare periodicamente nuove motivazioni. Limitandoci al solo ultimo cinquantennio, lo abbiamo visto rivestirsi dei panni della terza guerra mondiale, della vittoria certa del comunismo, della compromissione dell’ambiente a causa dello sviluppo economico e, da ultimo, della globalizzazione.
Inutile dire che, venuti meno la guerra mondiale e il comunismo, in questo periodo a farla da padrone è proprio il binomio ambiente / globalizzazione. Alla sua base c’è l’idea che il mondo è avviato sulla china dell’autodistruzione se non verranno messe in atto al più presto della politiche di salvaguardia ad amplissimo raggio e, soprattutto, ad altissimo costo. Tutto il resto dovrebbe passare i seconda linea rispetto alla emergenza ambientale – in senso lato – evocata con toni sempre più da ultima spiaggia.
Ma adesso un professorino danese, Biorn Lomberg, ancora relativamente giovane, se ne è uscito con un ponderoso libro (The Skeptical Environmentalist, L’ambientalista scettico, 2001), che smonta pezzo per pezzo il mito, dimostrandolo per quello che è: un mito, appunto. Va detto subito che il nostro ha tutte le carte in regola per occuparsi del problema: non solo insegna statistica alla prestigiosa università di Aarhus, e quindi sa come si maneggiano i numeri, ma era anche membro di Greenpeace, una delle associazioni più attive e anche aggressive nell’impegno ambientalista. E è stato proprio per nutrire la sua fede di argomentazioni dimostrate scientificamente che Lomberg si era messo a studiare l’impianto complessivo delle argomentazioni dei suoi colleghi di allora con il vecchio, solido metodo di guardare anzitutto ai dati. Sorpresa, sorpresa, ha invece finito con lo scoprire che le cose non stavano, anzi non stanno affatto come sostiene la mitologia ambientalista.
Il problema, manco a dirlo, è proprio nei dati. In .linea generale, se questi non sono usati con criteri oggettivi, rigorosi e soprattutto trasparenti, si può far dire loro praticamente qualsiasi cosa. Per esempio, attraverso scelte orientate: il grande sociologo americano Talcott Parsons usava dire che la conoscenza “è un sistema di orientamenti cognitivi alla realtà”, in altre parole che essa è un sistema di filtri mediante i quali noi decidiamo, magari inconsciamente, quali dati usare e quali no. E a volte non si tratta neppure di quali dati scegliere, ma di come presentarli. Se il prodotto interno loro è cresciuto lo scorso anno, poniamo, del 3%, un economista governativo lo rappresenterà su un grafico il cui asse verticale con l’origine magari a 90 – per cui il 3% in più copre un terzo della figura – mentre uno dell’opposizione sarà tentato di usare un grafico il cui asse ha l’origine a 0 - lo stesso 3% copre adesso un trentesimo della figura.
La serie di distorsioni che, partendo da questo approccio, Lomberg ha scovato nelle argomentazioni degli ambientalisti fondamentalisti è davvero impressionante. Quella che lui chiama la Litania – l’elenco minuzioso dei mali del mondo causati dall’industrializzazione e dal progresso e che si articolerebbero soprattutto nel peggioramento della condizione umana e nell’inquinamento – si rivela a un esame attento e basato sulle stesse fonti, l’ONU in primo luogo, un castello di esagerazioni, se non di mistificazioni. Non è vero che la gente stia peggio, prova ne sia che la durata della vita umana è aumentata in misura spettacolare, paesi in sviluppo inclusi. Non è vero che ci sia sempre più gente che non ha di che nutrirsi, si consumano molte più calorie pro capite adesso che non trent’anni fa, ancora paesi in sviluppo inclusi. Lungi dal peggiorare, tutti gli indicatori relativi alla distribuzione delle risorse, all’istruzione, al tempo libero, alla sicurezza personale, agli incidenti sono in costante miglioramento. Non è vero che la superficie della terra coperta da foreste si stia riducendo: tra il 1950 e il 1990 essa è passata dal 30,04% al 30,89 % (anche se negli anni Novanta potrebbe essersi verificata una lieve riduzione). Non è vero che corriamo il rischio di restare senza fonti energetiche e minerarie: già le sole riserve conosciute attualmente ci metterebbero in condizione di arrivare tranquillamente alla saldatura con quando disporremo di consistenti e crescenti fonti rinnovabili: E, forse soprattutto, nell’intero Occidente, originariamente la zona di gran lunga più compromessa del pianeta, la concentrazione di inquinanti nell’atmosfera è da trent’anni in rapida diminuzione, nonostante l’aumento della attività produttiva e della popolazione. A chi facesse l’esempio dell’inquinamento nelle città italiane lo scorso inverno, si potrebbe obiettare che a Londra buone politiche ambientali hanno fatto scendere la concentrazione di anidride solforosa nell’aria da 900 milligrammi per metro cubo nel 1850 e 300 nel 1950 e a meno di 50 poco prima del 2000. E anche i paesi in sviluppo sembrano avviarsi sulla stessa strada.
Perfino di acqua ce n’è in abbondanza, anche se la sua distribuzione lascia a desiderare. La verità è che i profeti di sventure, fra cui Lomberg cita espressamente Lester Brown del Worldwatch Institute e l’ex – vicepresidente Al Gore, ci dipingono un quadro che è l’esatto opposto della realtà. Non che le cose vadano bene in assoluto, anzi c’è ancora moltissimo da fare per rendere il mondo un posto in cui sia gradevole vivere. Però essere vanno meglio di una volta, il che significa che complessivamente la strada presa è quella giusta. In realtà per avere senso questo tipo di analisi deve basarsi, oltre che sui fatti, su misurazioni significative: il che vuol dire esaminare sistematicamente i trend di lungo periodo e confrontare le situazioni nel tempo e nello spazio. Molto spesso invece gli ambientalisti hanno elaborato le loro teorie confrontando i dati di un fenomeno in un dato anno con quelli di un anno successivo in cui esso si era modificato in peggio e trascurando magari tutti gli altri.
Così. per oltre 500 pagine corredate da un oceano di 2930 note, cifra dopo cifra, grafico dopo grafico Lomborg dipana la sua analisi, fredda, e tranquilla, per dimostrare che la nostra civiltà, nonostante tutto, è un successo e che non dobbiamo avere troppa paura del futuro. La validità del suo approccio è confermata dal clamore suscitato dal libro, uscito in inglese da appena sei mesi: alcuni ambientalisti fondamentalisti lo hanno attaccato con furore sul piano personale, accusandolo di essere praticamente un fascista, altri più avveduti lo hanno contestato su qualche errore marginale, che lui ha di buon grado riconosciuto, rafforzando così la validità complessiva del suo impianto analitico. Altri ancora hanno ammesso che distorsioni dei dati sono state effettuate, ma le hanno giustificate col fatto che senza continui e acuti gridi di allarme governi e popolazioni si sarebbero rilassati nella lotta contro il peggioramento della situazione. La cosa ricorda molto la risposta data da Jean Paul Sartre a chi gli chiedeva perché rimproverasse Kruscev per aver rivelato i crimini di Stalin: “Il ne faut pas desesperer Billancourt”, non si deve togliere la speranza a Billancourt, il grande quartiere operaio alle porte di Parigi. In altre parole, se spieghiamo ai lavoratori che Stalin era un criminale non troppo diverso da Hitler, gli operai perderanno lo stimolo della lotta di classe. Argomentazione contraria a qualsiasi principio di trasparenza democratica e che comunque non ha minimamente rallentato la caduta finale del comunismo.
Forse, in realtà, a Lomborg una critica gliela si potrebbe fare: egli lavora quasi esclusivamente su dati globali, mentre in alcune situazioni locali la situazione può essere effettivamente peggiorata nel recente passato (d’altra parte gli ambientalisti fondamentalisti sostengono che è la situazione complessiva del pianeta a peggiorare). Ma il suo lavoro resta in ogni caso un punto di svolta – in proposito è grave che in Italia se ne sia parlato molto poco – a partire dal quale il dibattito sullo “stato del mondo” non può più essere lo stesso di prima. In definitiva, quello che spaventa alcuni e affascina altri nella sua impostazione non è tanto il dibattito sulla situazione in sé, ma le conclusioni politiche che se ne possono trarre. Prima di tutto, con tutti i suoi difetti la nostra civiltà è la migliore che sia mai esistita – o, per dirla con Winston Churchill, è la peggiore, eccettuate tutte le altre conosciute - anche se si può, si deve migliorarla di moltissimo: ma non ci sarà nessun Doomsday. Poi, se la condizione e ancor più le prospettive ambientali non sono quelle descritte dalla vulgata corrente, allora anche le risorse disponibili per la lotta all’inquinamento potrebbero in parte essere impiegate ad altri fini, costruire più ospedali, più scuole, più case di riposo per gli anziani, più aiuti ai paesi arretrati del Terzo Mondo. Certo, in questo modo qualcuno perderebbe un po’ di potere: ma analizzare i problemi in modo razionale e stabilire le priorità logiche significherebbe agire in modo corretto e democratico, e quindi giusto, anche se ciò dovesse costare i lai di qualche demagogo.
Antonio Martelli