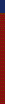back
A che servono gli scenari?
Il futuro è per sua natura incerto. Eppure, ogni giorno dobbiamo, volenti o nolenti, prendere delle decisioni che possono influire sul nostro futuro, oppure essere condizionate dalle nostre aspettative. Le conseguenze di queste decisioni possono essere buone o cattive a seconda di come il futuro evolverà. In che modo ci si può comportare razionalmente in una situazione del genere?
La risposta tradizionalmente data dalla teoria e dalla prassi del management è stata che esiste un solo futuro, sul quale si possono formulare delle ipotesi prima che esso si verifichi. In una forma più avanzata, questa risposta è stata ricompresa nella teoria delle decisioni in condizioni di incertezza. Ma nonostante i rilevanti progressi compiuto sul piano teorico, a livello pratico questi sono stati modesti, tanto da provocare in tempi recenti una evidente crisi di rigetto. In sostanza, molti hanno finito col concludere che i risultati ottenuti per creare un approccio razionale alle decisioni riguardanti il futuro non ricompensano gli sforzi compiuti.
Di qui il passo è stato breve a suggerire di riconcentrarsi più o meno esclusivamente sull'azienda in se'. Di questo giro di boa il prodotto più evidente è l'enfasi posta sul business process reingeneering. Naturalmente, alla sua radice vi sono anche altre cause altrettanto complesse: d'altronde, una delle sue conseguenze è proprio di mettere in secondo piano, se non proprio scartare del tutto, l'analisi strategica, che è rivolta essenzialmente all'ambiente esterno.
Il punto è che invece è proprio l'ipotesi che vi è un solo futuro a dover essere rimessa in discussione. Essa è alla radice sia dell'eccesso di rigida formalizzazione della pianificazione strategica, ormai fortunatamente relegata fra i ricordi, sia della più recente pretesa di poter fare a meno di previsioni, per concentrarsi esclusivamente su qualche "visione". Ma proprio perchè il futuro è incerto noi non possiamo sapere in anticipo come esso sarà. Anzichè chiederci che cosa succederà, dobbiamo quindi chiederci quali sono gli sviluppi possibili, o almeno probabili. Poichè quel che occorre è una strategia flessibile, ciò a cui bisogna puntare è un approccio flessibile alla previsione.
La cosa è tanto più necessaria in quanto, come è unanimemente riconosciuto, la nostra è un'epoca in cui i cambiamenti si succedono a ritmo sempre più accelerato: come ha osservato Gaston Berger, è proprio quando le ruote girano più in fretta che occorrono fari capaci di illuminare un più lungo pezzo di strada. Per risolvere questo problema sono state proposte parecchie soluzioni, basate in genere su qualche modello di simulazione quali quelli usati per predisporre e utilizzare i business games. Ma l'approccio che cresce forse più rapidamente è quello basato sulla elaborazione di scenari.
Il termine deriva ovviamente dal mondo del teatro, ma con un significato diverso da quello che gli si attribuisce usualmente: in inglese, da cui è tratto, esso indica la sintesi di una trama, la messa in evidenza degli eventi e dei personaggi che si susseguono sul palcoscenico. Nella relativa letteratura manageriale uno scenario contiene le storie alternative di eventi che devono ancora avvenire, il dispiegarsi contemporaneo di esiti diversi di una data situazione: Esso non implica il predicting, ma il forecasting.
Come ha osservato Robert Hailbroner, "scenario" è un termine drammatico. Esso implica che il futuro si sviluppa in modo incrementale, non casuale - che esso non deriva da cause sconosciute o imprevedibili, ma dal dispiegarsi di tendenze che sono già presenti nella struttura e nelle motivazioni della società. Naturalmente, tutto dipende dal saperle individuare. Gli scenari quindi sono in definitiva esercitazioni di analisi logica e il fatto che le previsioni in essi contenute siano poco attendibili è meno importante del fatto che è possibile ragionare in questo modo.
Agli scenari viene spesso rimproverato di non disporre di un insieme generalmente accettato di regole, di un "paradigma" di come essi debbano essere elaborati. In un certo senso, questo è del tutto vero. Naturalmente, esistono delle tecniche per elaborarli quali l'analisi morfologica, l'analisi di impatto della tendenza, l'analisi di impatto incrociato. Purtuttavia, data la grande flessibilità di utilizzo, si potrebbe anche arrivare a sostenere che vi siano tanti modi di elaborare scenari quanti scenaristi sono in circolazione. In realtà, alcune caratteristiche comuni sono abbastanza facilmente riconoscibili: ma il fatto che gli approcci siano eterogenei è un vantaggio, non un demerito, purchè naturalmente essi siano costruiti su premesse rigorose e verificabili.
Del resto, la loro stessa diffusione conferma esplicitamente la loro utilità. Già da tempo, la gran parte, se non tutte, le prime 500 aziende americane analizzate da Fortune fanno più o meno ampio uso di scenari. Anche in Europa aziende ed enti di varia natura vi ricorrono sempre più sistematicamente, fra essi, la Eléctricité de France, la ESA (European Space Agency), la Bayer, la Unilever, le britanniche British Airways, Cable and Wireless e ICL, la svedese Electrolux, nonché la FIAT e l'AGIP.
Un esempio abbastanza illuminante è l'uso degli scenari presso la Volkswagen. Come tutti sappiamo, il mercato automobilistico si sta differenziando sempre più e a crescente velocità. Emergono nuove nicchie che riducono la dimensione dei segmenti di mercato per i vari modelli: e d'altronde solo coloro che possono offrire un prodotto adatto al momento giusto possono trarre redditività dai loro investimenti. L'imperativo concorrenziale deve quindi essere riassunto in questo modo: "dobbiamo produrre prima del bisogno e non per il bisogno".
Secondo l'azienda automobilistica tedesca queste differenze e le nicchie loro connesse possono essere meglio individuate e previste nel loro sviluppo per mezzo di scenari. L'analisi mediante scenari deve tuttavia essere rivolta all'esterno: l'osservatore dovrebbe collocarsi entro lo scenario, perchè questo è l'unico modo per veder descrivere tanto le tendenze quanto le fluttuazioni. A questo fine, le procedure tradizionali dell'analisi di mercato per mezzo di questionari e stime statistiche sono in pratica irrilevanti.
Un esempio di questo approccio tratto dal passato è il caso della Golf GTI, una automobile compatta dall'aspetto sportivo, del tutto atipica quando venne concepita negli anni Settanta.
Secondo il modo di pensare dell'epoca, un'analisi del potenziale di mercato per un'auto di questo tipo non avrebbe messo in evidenza volumi di vendita adeguati. Ma il suo successo dimostrò che questo modello cresceva "secondo il suo scenario", divenendo il simbolo di un ben definito stile di vita. Fu il prodotto a dare impulso alla crescita di questo stile: all'inizio degli anni Novanta le vendite della Golf GTI avevano superato il milione di unità.
L'elaborazione di scenari alla Volkswagen si basa su esperienze che si sono protratte ormai per una quindicina d'anni. La conoscenza delle tendenze di base nelle esigenze e nei valori dei clienti è essenziale per una pianificazione riuscita di modelli che abbiano un elevato valore finale per il cliente. Gli scenari vengono costruiti da gruppi interdisciplinari di persone provenienti dal marketing e dalla produzione dei quattro marchi VW, Audi, Seat e Skoda. Essi forniscono il riferimento alla pianificazione e ai processi strategici, il che vuol dire che nei singoli processi e progetti si utilizzano informazioni derivanti dallo scenario.
Una accusa che viene a volte mossa all'approccio mediante scenari è che essi sono sì molteplici, cioè mettono in evidenza più futuri possibili: ma si tratta di futuri pur sempre basati su qualche ipotesi di continuità (per esempio, una crescita alta, media e bassa). L'accusa, tuttavia, non tiene conto del fatto che, una volta costruiti, gli scenari vanno poi utilizzati: e nel loro utilizzo devono avere un ruolo importante sia proprio la creatività del management, sia le implicazioni possibili.
Il modo per introdurre la discontinuità, essenziale per ragionare in termini strategici, è quello di introdurre ipotesi "... what ... if". Una variante di questo è il cosiddetto metodo dell'aggravamento spinto, che consiste nel derivare dallo scenario una ipotesi molto positiva, oppure molto negativa, e valutarne le conseguenze in termini strategici ("se tutto andasse bene o male in quale situazione ci ritroveremmo?").
Indubbiamente, gli scenari hanno trovato finora il loro terreno ideale di applicazione nelle aziende transnazionali, probabilmente per la maggiore facilità di creare interfacce ben funzionanti fra i vari settori coinvolti nella elaborazione di scenari ed, eventualmente, fra questi e gli esperti esterni. Tuttavia, alcuni segnali sembrano indicare un crescente interesse a questo tipo di approccio alla strategia, nel quadro di un profondo ripensamento delle finalità e della natura di quest'ultima, anche da parte delle aziende medio grandi e medie.
Spesso però in queste aziende sussistono due remore ad adottarli. La prima riguarda i costi: ma in realtà un normale scenario ben costruito non dovrebbe costare più di una ricerca di mercato di media portata. La seconda remora riguarda la possibilità di utilizzo, una volta elaborati, da parte di staff interni in genere poco numerosi, soprattutto dopo le grandi ristrutturazioni e connesse esternalizzazioni di funzioni avvenuti in questi ultimi anni. Questa preoccupazione ha un suo fondamento: d'altra parte tuttavia, essa potrebbe venire addotta per qualsiasi tipo di analisi che non risponda a preoccupazioni contingenti e immediate. Un'azienda che non sappia trovare spazi e tempi da dedicare alla riflessione e progettazione del proprio futuro rinuncia implicitamente a una quota rilevante, decisiva forse, del suo vantaggio competitivo.
In definitiva, a che servono gli scenari? Non a prevedere il futuro, ma a ragionare intorno ad esso in modo da elaborare uno schema coerente per le nostre decisioni. Ma essi servono anche a insegnarci alcune altre cose. Più di tutto, possono indurre il management, in senso lato, ad accettare in modo costruttivo ipotesi anche spiacevoli. Possono servire a sottolineare che ormai la rapida integrazione delle varie economie obbliga un numero crescente di aziende a ragionare al di là del proprio mercato nazionale e a pensare strategicamente in termini europei, se non mondiali. E infine, elaborare scenari può contribuire a togliere di mezzo un falso problema che può avere però conseguenze perverse: quello della contrapposizione fra creatività e analisi. In realtà sono ambedue indispensabili.